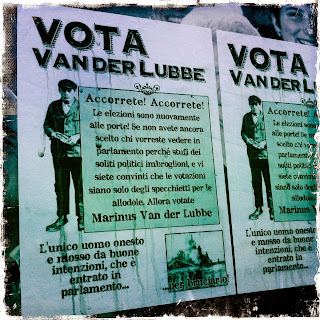Prima campione, poi autore di successo, infine "marchio" e motivatore degli uomini d'affari. La sua forza? "Ho smesso di voler essere perfetto"
di Giuseppe De Bellis
Andre Agassi parla al contrario di come giocava. Piano. Sottile la voce, precise le parole. Se parla di tennis non sta parlando solo di tennis. È finito il match ed è cominciata la vita: si veste di nero, minimalista. Ha tolto tutti i colori, tutti gli accessori: gli orecchini, la barba, quel che restava dei capelli. Ora è un Amleto calvo, ha scritto qualcuno: sopravvissuto ai dubbi, ai tormenti e al suo regno. «Non si è ucciso, anzi si è ritrovato, con parole che lasciano il segno».
Ha scavalcato il suo sport, la sua carriera, il successo, la fama, i soldi. Ha superato pure la autobiografia che ha raccontato chi è davvero. È altro. Uno Steve Jobs che invece di cominciare coi computer ha cominciato con un Drago che gli sparava «2500 palline al giorno, cioè 17500 a settimana, cioè un milione all'anno». È passato oltre: uno in grado di ispirare. Un guru. Un intellettuale della vita. Uno che racconta la sua storia per spiegare come farcela. L'ha fatto ad Harvard, qualche mese fa; lo fa oggi a Milano, al World Business forum: un posto per ascoltarlo costa dai duemila euro in su. Manager, imprenditori, professionisti pagano per quella voce e per quelle parole. Racconta ciò che ha imparato, ciò che l'ha cambiato. Si può vincere anche contro se stessi: «Odio il tennis, lo odio con tutto il cuore, eppure continuo a giocare. Per quanto voglia fermarmi non ci riesco. Continuo a implorarmi di smettere e continuo a giocare, e questo divario, questo conflitto, tra ciò che voglio e ciò che effettivamente faccio mi appare l'essenza della vita». Sta tutto qui il passaggio tra ieri e oggi, tra il giocatore e il motivatore, tra lo spettro di diventare un reduce come molti altri e la capacità di evolversi in qualcosa di diverso. Open ha modificato la percezione che il pubblico planetario aveva di Agassi: il ragazzino viziato e precoce e strafottente diventato un uomo capace di gestirsi, di affrontare pubblicamente il rapporto con un padre ossessivo, di svelare la necessità di provare la droga e la disumanità di affrontare il divorzio da Brooke Shields via fax. «Non è un libro sul tennis», dice ora. Lo ripete a se stesso e agli altri. Trecentomila copie vendute solo in Italia, un caso letterario strano, cominciato tardi e proseguito come un'onda che non trova scogli: il libro è uscito quasi tre anni fa ed è ancora in classifica. L'ha detto: «Voi mi avete capito, siete ricettivi. Ho sempre avuto questa sensazione, anche quando giocavo, voi sentivate che ce la mettevo tutta, che cercavo una quadratura, di mettere i pezzi insieme, anche nella vita. Ci mettevo passione, voglia, allenamento, pure nei miei sbagli. Ero disturbato, ma voi sembravate non farci caso. Davo l'idea di un bullo arrogante, ero solo pieno di ansie. C'è gente che dentro il campo rinasce, diventa leone, si sente finalmente bene, io invece stavo male da cani. Bastava un ritardo per la pioggia e già cadevo in confusione, mi venivano i dubbi, le incertezze. È stato brutto vivere così, anzi patire. L'autobiografia l'ho voluta, mi sono dilaniato, sbranato, sono andato a fondo, ho scelto J. R. Moehringer, per scriverla, non perché è un premio Pulitzer, ma perché mi era piaciuto Il bar delle grandi speranze. Avevo più da perdere che non da guadagnare». È nelle mani di chi non ha mai impugnato una racchetta, lo vedi. È quel pubblico che l'ha trasformato in santone laico. Dentro la gente ci ha trovato onestà e ispirazione. È la parola che ripete più spesso il suo manager Steve Miller: «Inspiration». È la chiave che apre la porta: chi lo va ad ascoltare oggi cerca quello. Nessuno ricorda come giocasse, a nessuno importa che il tennis di oggi sia figlio dei suoi piedi piantati dentro il campo. Oltre, appunto. Di più. Ciò che allontana un uomo dal suo passato senza dovere a tutti i costi accartocciarlo.
Agassi oggi è un brand. Il marchio del successo. Trascendendo la condizione di sportivo ha messo dietro quelli che sono rimasti appesi ai loro ricordi, quelli che vivono nella nostalgia. Sampras è stato più forte di lui. McEnroe pure. Però sono tennisti, punto. Agassi no. Rimasto agganciato dall'esterno, il resto è altro: una fondazione e una holding che mescolano la charity con il business, la bontà con gli affari. Agassi e la moglie Steffi Graf aiutano le scuole di mezz'America con i soldi delle loro donazioni. Gli altri, molti, li investono: Andre ha appena comprato un'azienda che produce snack per ragazzini. Li vuol aiutare a mangiare meglio, dice con un'operazione di crossmarketing che unisce il benefattore all'imprenditore. Gli sponsor credono in lui: Longines soprattutto che da una vita lo segue, lo coccola, lo ama. Nike, adesso, di nuovo. Dopo otto anni di pausa, l'azienda che costruì il personaggio Agassi, l'ha ripreso, l'ha rivoluto, l'ha pregato: «Torna». È quello che gli ha chiesto anche il mondo del tennis. Perché non rientra? Ci sarebbe bisogno di lei? «Non fa per me». Lo guarda, il tennis. Ma non l'odiava?, gli chiedi. Lui: «Non era e non è amore-odio. È odio-amore, odi et amo». Lo dice in latino, usando Catullo e lasciando in sospeso il resto della citazione. Vola in quell'Europa che ha smesso di odiare perché non gli costa più la fatica di dover combattere con la schiena che l'ammazzava dal dolore appena finiva l'effetto delle medicine. Viene in Italia. L'hanno invitato pur sapendo che è timido come pochi. Al Business Forum non farà un discorso, risponderà a domande. Non c'è bisogno di parole particolari per trasmettere ciò che hai dentro. È il ritmo, come nel tennis: «Non è uno sport di tecnica e di forza. È il ritmo che fa la differenza». La voce non alza il volume, cambia solo la frequenza. Dice che è giusto così. È quello che ha imparato e che trasferisce. Perché lui è il Brad Gilbert degli altri: di chi teme di non potercela fare a portare avanti un'azienda, di chi ha paura di sbagliare con il mercato, di chi si sente inadeguato. Sapete che dice? «Io sono cambiato quando ho smesso di voler essere perfetto. Ho deciso di essere perfezionista del non essere perfezionista». È stato Gilbert e il suo «gioca sporco». È ciò che ripete su ogni palco dal quale parla, in ogni convention a cui viene invitato. Il tennis è un pretesto, ecco perché funziona. Ecco lo Steve Jobs di un altrove. Il campo è banalmente una metafora. Il business è uguale, il mercato pure, le relazioni con gli altri, siano colleghi o familiari, idem. È uno scambio in cui lui ha capito come diventare più forte: «Semplicemente sapevo dove andava la pallina anche quando sbagliavo, a differenza di tutti quelli che lo sapevano solo quando facevano il colpo giusto. Questo mi ha migliorato». Si è osservato e si è visto. Si osserva e si vede ancora.
Qualche tempo fa, gli hanno fatto il questionario di Proust: Qual è il tuo attuale stato d'animo? «Contenuto, ma in attesa». Qual è la persona vivente che più ammiri? «Mia moglie». Qual è la tua più grande paura? «Lasciare le persone che amo». Che cosa deplori di più in te stesso? «A volte sono stato accecato dalla lealtà». Che cosa deplori di più negli altri? «La slealtà». Che talento vorresti avere? «Quello di Roger Federer». Se potessi cambiare una cosa di te, che cosa sarebbe? «Essere meno instabile e ossessionato da domande come questa». Che cosa consideri come la miseria più bassa? «Svegliarsi un giorno e non essere in grado di distinguere i buoni dai cattivi nella mia vita». Qual è la tua occupazione preferita? «Non l'ho ancora trovata». Qual è il tuo motto? «Mai portare un coltello per uno scontro a fuoco». Come vorresti morire? «All'alba del 22° secolo, facendo qualcosa che odio».
Questa cosa non è il tennis. Perché manca il resto. Manca Catullo e ciò che ne discende. «Odio e amo. Per quale motivo io lo faccia, forse ti chiederai. Non lo so, ma sento che accade, e mi tormento». Ventidue parole per spiegare tutto e tutti, perché ognuno di noi ha un drago che ti fa odiare ciò che fai e ciò che in fondo ami. È la condivisione dell'esperienza che ha reso Agassi diverso dagli altri grandi: non piaceva a un sacco di gente, piace. Ascoltandolo si capisce perché.
(pubblicato su Il Giornale del 7 novembre 2013)